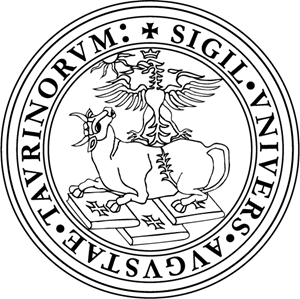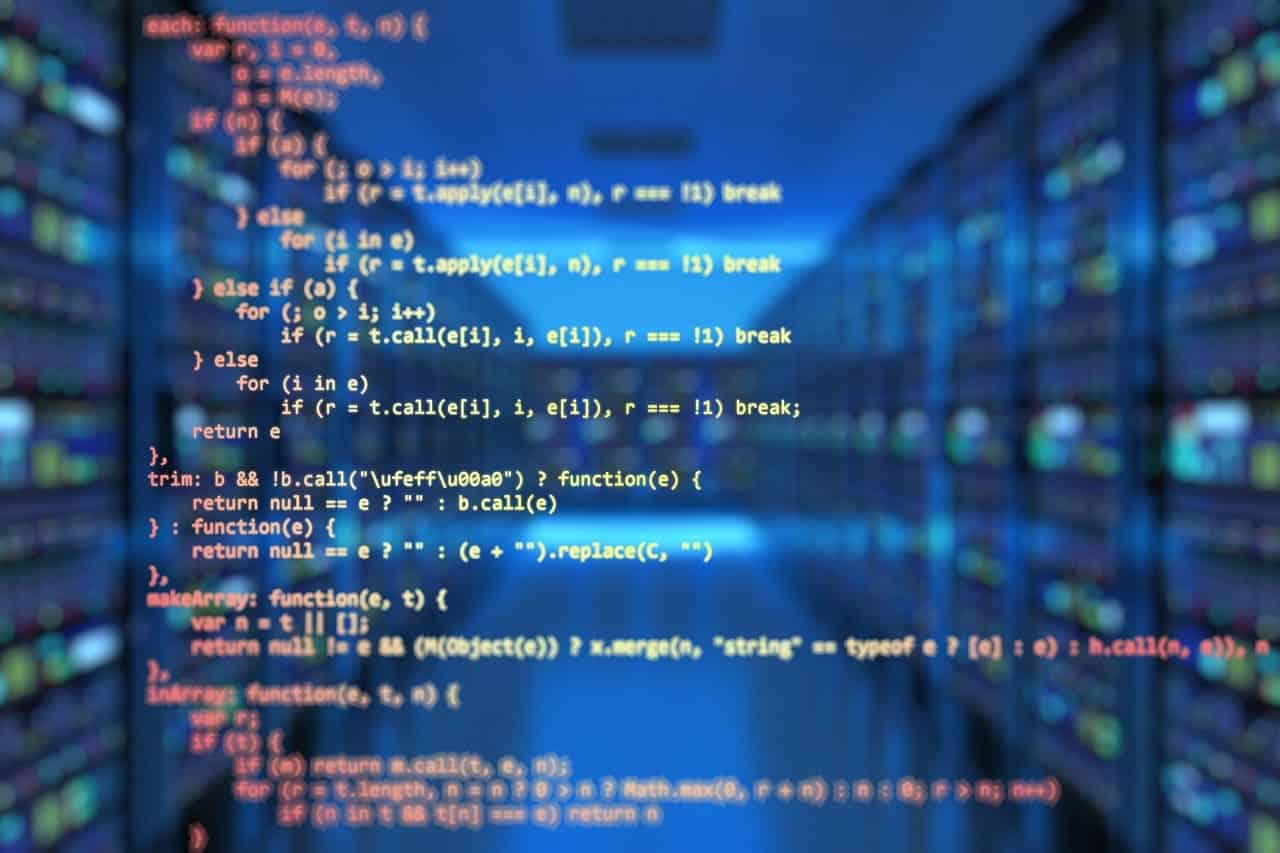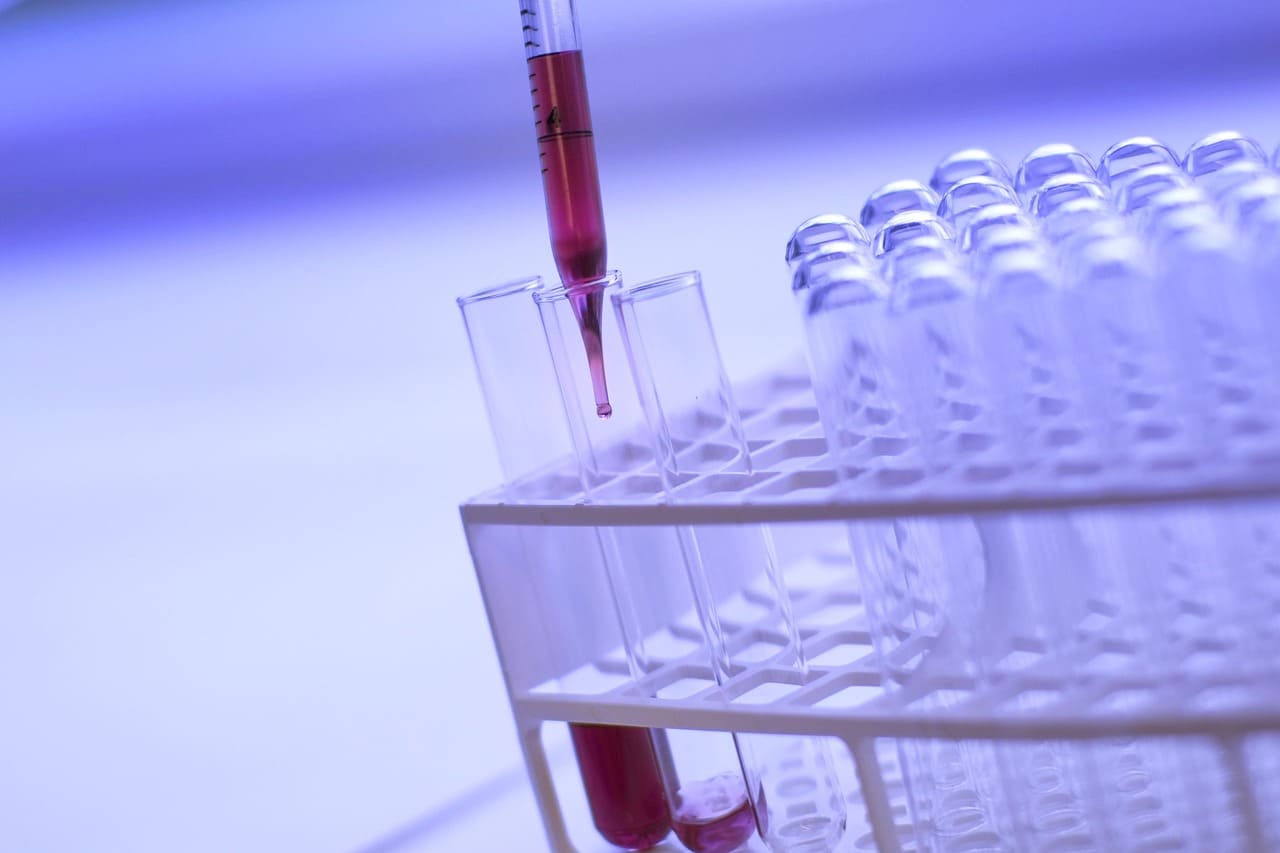Filologia, letterature e storia dell'antichità (TORINO)
Descrizione
Obiettivi formativi
Il corso magistrale dell'Università di Torino offre una formazione specialistica nel campo degli studi classici, con l'obiettivo di formare esperti capaci di analizzare le civiltà antiche attraverso le loro fonti testuali. Il corso mira a fornire una conoscenza approfondita dei testi greci e latini, analizzati direttamente in lingua originale con le più aggiornate metodologie scientifiche: filologica, linguistica, letteraria, storica e papirologica.
Piano di studi
Il percorso biennale prevede un primo anno di consolidamento delle competenze caratterizzanti (linguistiche, filologiche, storiche) e un secondo anno di approfondimento, spesso in contesti seminariali. Particolare attenzione è data alla prospettiva interdisciplinare, con insegnamenti che esplorano la ricezione dell'antico nelle epoche successive (dal medioevo al contemporaneo) e le nuove frontiere dell'informatica umanistica (Digital Humanities).
Competenze acquisite
I laureati possiedono elevate capacità di traduzione, commento e interpretazione critica delle fonti letterarie e documentarie del mondo antico. Acquisiscono gli strumenti per condurre una ricerca scientifica autonoma, per insegnare le discipline classiche con competenza e per applicare le metodologie filologiche all'analisi di qualsiasi tipo di testo. Sviluppano inoltre competenze digitali per la gestione e l'analisi di corpora testuali e banche dati.
Sbocchi professionali
Impatto I.A.
Il campo degli studi classici sta vivendo una rivoluzione grazie all'I.A. e alle Digital Humanities. Tecnologie di Trascrizione Testuale Manuale (HTR), come Transkribus, automatizzano la lettura di manoscritti e papiri, rendendo accessibili enormi quantità di testi. L'I.A. viene usata per l'analisi stilometrica per determinare l'attribuzione di opere anonime, per il topic modeling al fine di scoprire temi ricorrenti in vasti corpora, e per ricostruire digitalmente frammenti di iscrizioni o testi danneggiati.
Per il filologo del futuro, l'opportunità è di poter affrontare domande di ricerca su una scala impensabile in passato, passando dall'analisi del singolo testo all'interrogazione di intere biblioteche digitali. La sfida è duplice: da un lato, non perdere il rigore ecdotico e l'attenzione al dettaglio materiale del singolo manoscritto; dall'altro, sviluppare un approccio critico verso gli strumenti computazionali, comprendendone i margini di errore e i bias. L'umanista deve diventare un curatore critico dell'output algoritmico.
Diventa imprescindibile acquisire competenze in Informatica Umanistica. Conoscenze di base di linguaggi di marcatura come XML-TEI (Text Encoding Initiative) per la codifica dei testi sono fondamentali. Sarà utile sviluppare familiarità con linguaggi di scripting come Python per l'analisi testuale e con software per la visualizzazione di dati e l'analisi di reti (es. Gephi), per mappare le relazioni tra personaggi o la diffusione di idee.
Preparati al futuro
Lista di azioni prioritarie da iniziare a padroneggiare da subito per restare rilevante e competitivo.
Competenze da sviluppare
Codifica di testi con XML-TEI
Imparare i fondamenti della Text Encoding Initiative, lo standard per la rappresentazione digitale dei testi. Svolgere esercitazioni pratiche di marcatura di un breve testo classico, seguendo le linee guida e i tutorial disponibili online (es. TEI by Example).Text mining e analisi stilometrica con Python o R
Acquisire le basi di un linguaggio di programmazione per condurre analisi quantitative sui testi. Seguire corsi come Programming Historian per imparare ad analizzare frequenze di parole, concordanze e a usare pacchetti per la stilometria come Stylo in R.Trascrizione automatica di manoscritti (HTR)
Imparare a usare piattaforme come Transkribus. Allenarsi a creare un modello di I.A. per la trascrizione di un set di immagini di un manoscritto, apprendendo le fasi di training, valutazione e correzione.Routine di successo
Esplorazione settimanale di un progetto di digital humanities
Navigare e analizzare un progetto digitale di riferimento (es. Perseus Digital Library, Trismegistos). Capire quali tecnologie usa, come sono strutturati i dati e quali nuove domande di ricerca permette di porsi.Seguire il Journal of Digital Humanities
Leggere regolarmente articoli da riviste accademiche specializzate per rimanere aggiornati sui metodi computazionali più recenti applicati agli studi umanistici e sulle relative discussioni critiche.Esperienze utili
Tirocinio o tesi in un progetto di digital philology
Scegliere un percorso che permetta di collaborare attivamente a un'edizione digitale, alla creazione di un database o alla digitalizzazione di un fondo archivistico. L'esperienza pratica è insostituibile.Partecipare a una summer school' in digital humanities
Candidarsi per scuole intensive che offrono una formazione pratica su strumenti e metodi digitali (es. la European Summer University in Digital Humanities a Lipsia). Sono ottime per il networking e l'apprendimento intensivo.Creare una piccola edizione digitale personale
Scegliere un breve testo (un'epigrafe, una poesia) e creare una semplice edizione digitale con commento e marcatura TEI, pubblicandola su una pagina GitHub. È un progetto-portfolio di grande efficacia.Segnala un problema
Scopri corsi
Altri percorsi formativi in Scienze dell’antichità, filologico‑letterarie e storico‑artistiche
Sfoglia le carriere
Aree di studio
Esplora le aree di studio
Progetta la tua carriera da protagonista
Una consulenza mirata può farti evitare errori costosi e indirizzarti verso il percorso più promettente