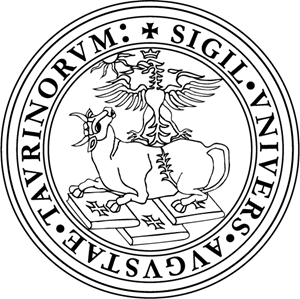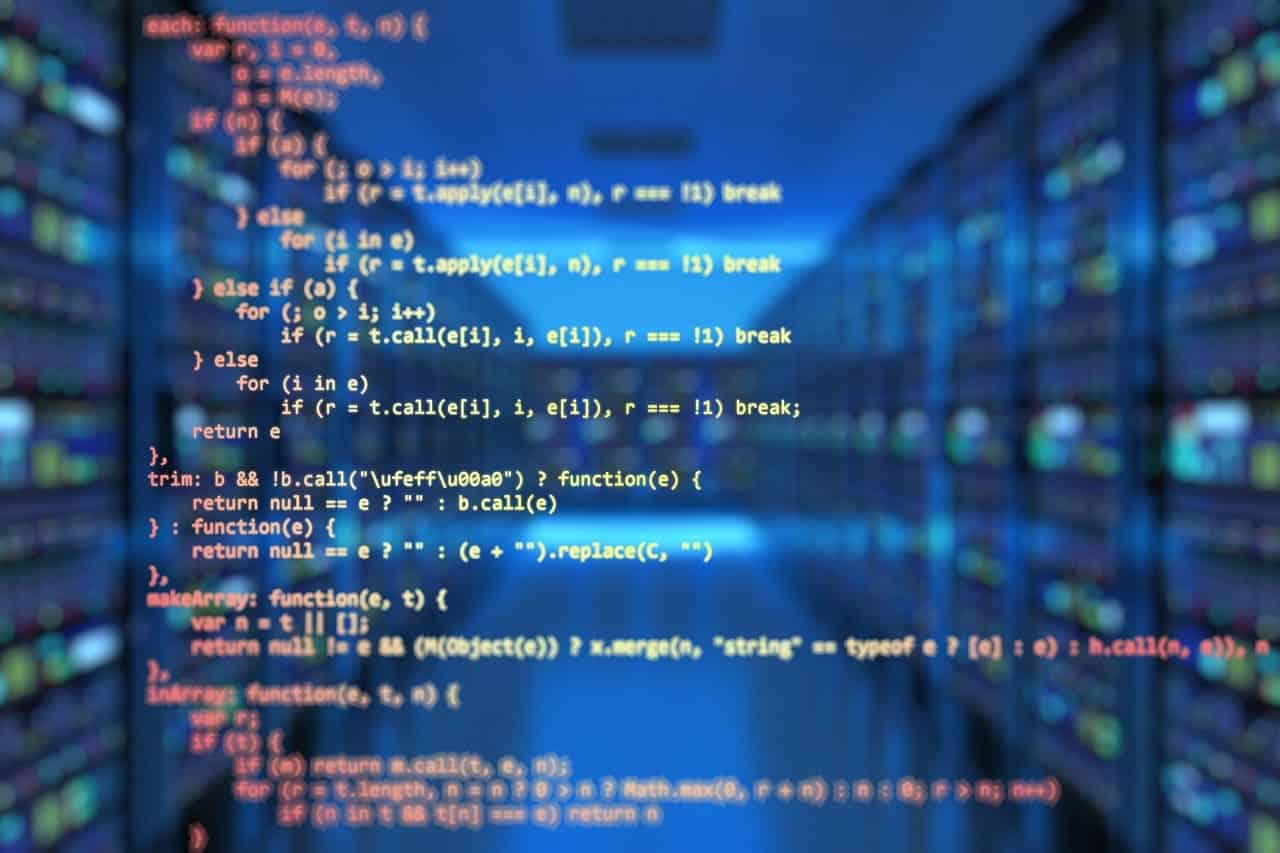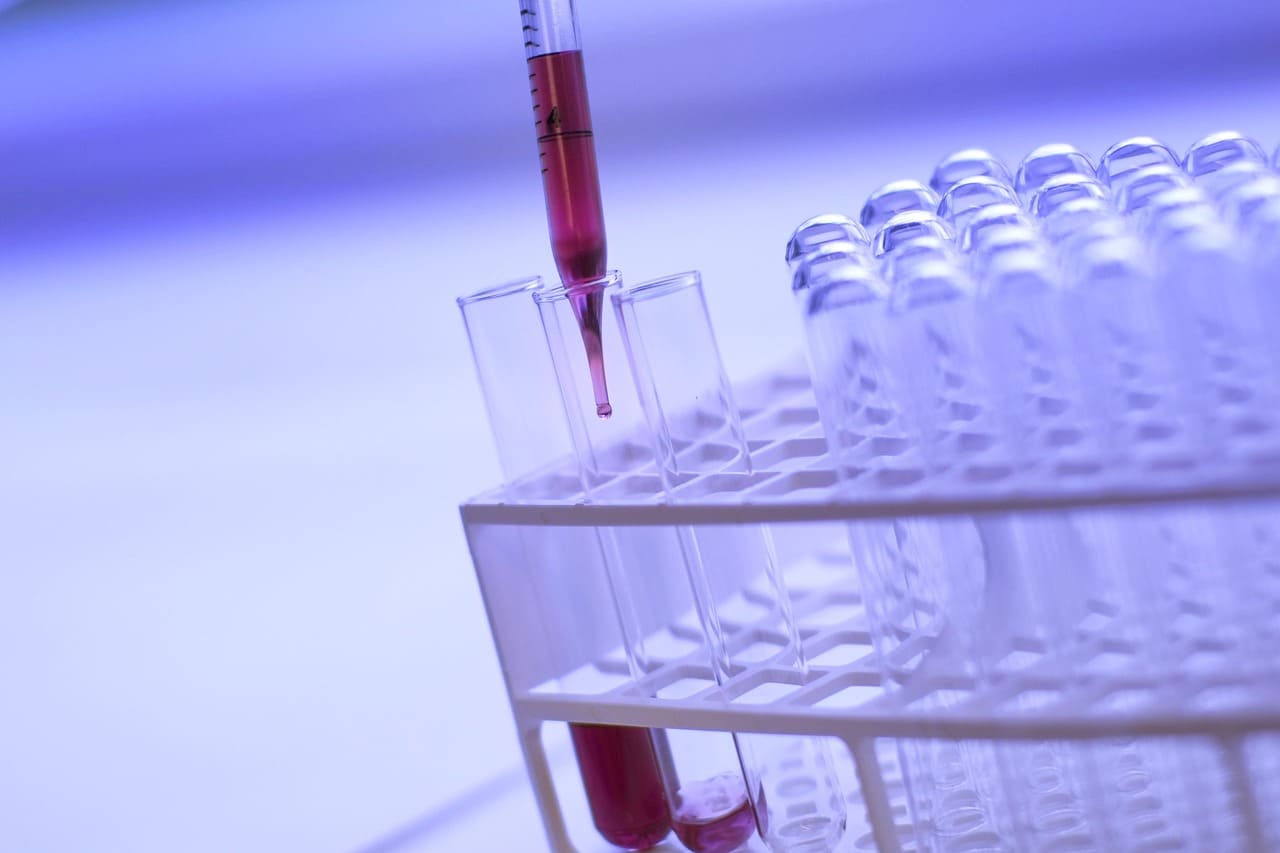DOTTORATO IN SCIENZE ARCHEOLOGICHE, STORICHE E, STORICO-ARTISTICHE
Descrizione
Obiettivi formativi
Il Dottorato di Ricerca in Scienze Archeologiche, Storiche e Storico-Artistiche dell'Università di Torino forma ricercatori di alto profilo nelle discipline umanistiche. L'obiettivo è sviluppare la capacità di condurre ricerca scientifica autonoma e originale, basata su un forte rigore critico e filologico, ma con una dimensione fortemente interdisciplinare e aperta alle nuove metodologie delle digital humanities.
Piano di studi
Il percorso è incentrato sullo sviluppo di un progetto di tesi di dottorato individuale, che rappresenta un contributo significativo alla conoscenza nel proprio campo di studi. La formazione è arricchita da seminari avanzati, workshop metodologici e periodi di ricerca all'estero. Il programma promuove l'interazione tra le diverse discipline (archeologia, storia, storia dell'arte) e la sinergia con l'informatica e le scienze esatte per l'analisi del patrimonio culturale.
Competenze acquisite
I Dottori di Ricerca acquisiscono la piena padronanza del metodo critico e degli strumenti di ricerca specifici della propria disciplina. Sviluppano elevate capacità di analisi delle fonti, di argomentazione complessa e di comunicazione scientifica a livello internazionale. La formazione prepara alla carriera nella ricerca accademica e a ruoli di alta responsabilità in istituzioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale (musei, archivi, soprintendenze).
Sbocchi professionali
Impatto I.A.
La ricerca umanistica è stata trasformata dall'approccio computazionale, e l'I.A. ne è la frontiera più recente. L'impatto si manifesta su tre livelli: digitalizzazione (OCR/HTR per trascrivere fonti manoscritte), analisi (computer vision per l'analisi stilistica di opere darte, NLP per il topic modeling di testi storici, network analysis per mappare relazioni) e valorizzazione (realtà virtuale e aumentata, chatbot museali, sistemi di raccomandazione personalizzata per i visitatori).
Per un dottorando, l'opportunità è di poter porre domande di ricerca nuove e su una scala senza precedenti, integrando l'analisi qualitativa tradizionale con quella quantitativa su big data culturali. La sfida è diventare un ricercatore ibrido: mantenere il rigore ermeneutico e la sensibilità al contesto, ma acquisendo le competenze computazionali per gestire questi nuovi tipi di fonti e strumenti. È cruciale sviluppare un approccio critico verso la tecnologia, interrogandosi sui bias presenti nei dati e negli algoritmi.
Le competenze in digital humanities non sono più un extra, ma una componente essenziale della formazione dottorale. È necessario acquisire familiarità con le basi della programmazione (Python/R) per l'analisi di testi e dati, con i software GIS per l'analisi spaziale, con gli standard di metadatazione semantica (LOD) e con le piattaforme per la creazione di archivi e mostre digitali. La capacità di progettare e gestire un progetto di ricerca digitale è una skill' chiave.
Preparati al futuro
Lista di azioni prioritarie da iniziare a padroneggiare da subito per restare rilevante e competitivo.
Competenze da sviluppare
Computational research methods
Acquisire solide competenze pratiche in almeno un'area computazionale rilevante per la propria ricerca: analisi del testo, network analysis, GIS, o computer vision. Seguire i workshop e i corsi offerti da centri di digital humanities e da piattaforme come The Programming Historian.Data management e digital curation
Imparare a scrivere un Data Management Plan (DMP), a organizzare i dati della ricerca in modo strutturato e a utilizzare metadati standard. Acquisire familiarità con i principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) per i dati della ricerca.Progettazione e gestione di progetti digitali
Imparare le basi del project management applicato alla ricerca umanistica. Saper definire gli obiettivi, le risorse, la timeline e i deliverable di un progetto di digital humanities, anche piccolo. Usare GitHub per la gestione del progetto.Routine di successo
Mantenere un blog di ricerca
Aprire un blog o un sito web personale per documentare il progresso della propria ricerca, condividere riflessioni metodologiche e pubblicare piccole analisi. È un modo per praticare la scienza aperta (open science) e per costruire una propria visibilità scientifica.Partecipare alla community delle digital humanities
Iscriversi a mailing list come Humanist e seguire su X (Twitter) l'hashtag #digitalhumanities. Partecipare alle conferenze di settore (es. quelle dell'AIUCD - Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale).Esperienze utili
Scegliere un progetto di tesi che integri metodi computazionali
La tesi di dottorato è l'occasione principale per acquisire competenze di ricerca avanzate. Scegliere un argomento che permetta di sperimentare e padroneggiare le metodologie digitali è un investimento cruciale per il futuro.Trascorrere un periodo come visiting scholar in un centro di digital humanities
Fare un'esperienza in uno dei centri di eccellenza in questo campo (es. in King's College London, Stanford, o altri centri della rete DARIAH) permette un'immersione totale in un ambiente di ricerca interdisciplinare e innovativo.Pubblicare i risultati su riviste e formati diversi
Oltre all'articolo scientifico tradizionale, imparare a comunicare la propria ricerca attraverso formati digitali: un saggio visuale, una mappa interattiva, un database online. Dimostra versatilità e una profonda comprensione della comunicazione scientifica moderna.Segnala un problema
Scopri corsi
Altri percorsi formativi in Scienze dell’antichità, filologico‑letterarie e storico‑artistiche
Aree di studio
Esplora le aree di studio
Progetta la tua carriera da protagonista
Una consulenza mirata può farti evitare errori costosi e indirizzarti verso il percorso più promettente